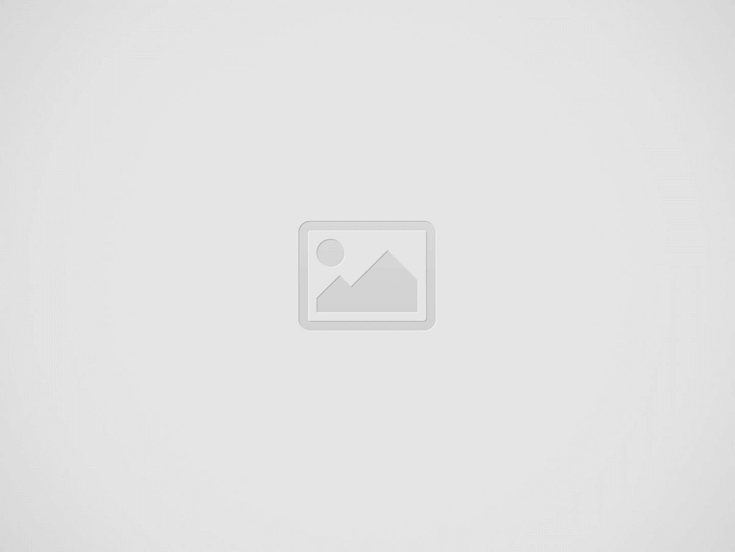

Nel 1918 in un elegante palazzo del centro di Milano il giovane Ernest Hemingway fu ricoverato e curato per le ferite ricevute sul fronte italiano della Grande guerra. Cento anni dopo rimane la lapide che ricorda quei giorni, e rimane la domanda di fondo su un autore che è diventato – in una certa misura con compiacimento, in un’altra suo malgrado – “l’icona dello scrittore americano del Novecento”, ma che anche è stato schiacciato dalla sua stessa immagine e, come scrisse Italo Calvino già negli anni Cinquanta, da quella “filosofia di vita di cruento turismo”, diventata presto, nella temperie della contemporaneità, per molti insopportabile. Era il prezzo da pagare per una popolarità che Hemingway seppe impersonare come pochi altri? Forse sì, ma sotto il suo celebre iceberg c’era, anche in questo caso, molto di più. “Oltre le dolcezze dell’Harry’s Bar e le tenerezze di Zanzibar, c’era questa strada, oltre le illusioni di Timbuctù e le gambe lunge di Babalù, c’era questa strada”. Non sappiamo esattamente dove sia “questa strada” che Paolo Conte ha magnificamente messo in bocca al suo Hemingway, però un testimone diretto ci assicura che quel giovanotto con un sorriso alla Tom Cruise è riuscito a rompere “il velo tra letteratura e vita” e dato che quel testimone si chiama James Joyce ecco che il quadro diventa ancora più interessante. Così sarà ancora bello pensare i due che nella Parigi degli anni Venti, insieme al biondissimo Scott Fitzgerald, fanno a pugni con il colosso del Modernismo, giocando ciascuno la propria solitaria ed epocale partita. Parigi, appunto. Quella stagione da espatriato che Hemingway ha raccontato al meglio nelle pagine di “Fiesta”, il suo romanzo d’esordio uscito nel 1926 che, accanto ad “Addio alle armi” e ad alcuni dei “49 racconti”, resta probabilmente la cosa migliore che abbia mai scritto.[irp]
Possiamo dimenticare la ritrita citazione sulla “Generazione perduta” di Gertrude Stein, perché oggi serve a poco, perché oggi pesa molto di più la lezione formale del romanzo, il suo procedere per dialoghi impellenti, necessari; il suo dare una forma essenziale all’idea di “morale pratica” di fronte all’insondabilità di ogni cosa, Parigi – o la Spagna e le corride, scegliete voi – in cui si imbattono i suoi protagonisti. “A me non importava di sapere cosa fosse tutta la faccenda – dice a un certo punto il narratore Jake Barnes -. M’importava di sapere come vivere, nella faccenda. Forse però se scoprivate come viverci potevate anche capire cosa l’intera faccenda fosse”. Shakespeare, chiaramente, passava di lì in quel momento, ma la grandezza di Hemingway era tutta nella noncuranza apparente di quella relazione con la Letteratura con la elle maiuscola. “Chiama le cose come le vedi – dirà a un certo punto l’anziano scrittore alla platea dei suoi ammiratori – e al diavolo tutto il resto”. Comunque la vogliate vedere, questa resta una lezione importante. Poi c’è tutto il resto, ovviamente: la retorica, la caccia, l’alcol, i libri brutti, le tristissime gare di sosia cui siamo obbligati ad assistere, i cocktail con il suo nome, troppe mogli, un fucile e una domenica mattina scandalosamente radiosa. La tristezza e la solitudine che il successo portava con sé. Le fotografie di una vita “sportiva” che mostrano quanto fossero diverse le facce di Hemingway, come sembrasse a volte giovanissimo, a volte decrepito, a volte semplicemente un giornalista spaventato, a volte tutte le cose contemporaneamente. Saul Bellow ha scritto che “la felicità cui Hemingway aspira deriva spesso dalla sospensione del ricordo”. Forse questo è il luogo in cui fermarsi, quel “posto pulito e illuminato bene” dove la notte non riesce ad arrivare e dove il tempo, cantava Enrico Ruggeri, non era ancora scaduto.[irp]