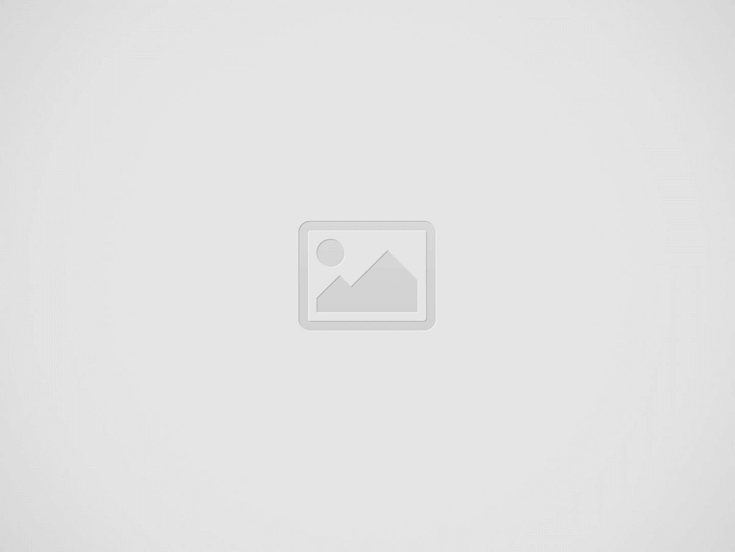

Divya Salaskar, daughter of slain Indian policeman Vijay Salaskar, pays respects at the Police Memorial, during an event to commemorate the 10th anniversary of the 2008 Mumbai militant attacks in Mumbai on November 26, 2018. - Ten years ago Islamist militants from Pakistan laid siege to India's financial capital Mumbai for three days, killing 166 people and injuring hundreds more. (Photo by - / AFP)
Dieci anni dagli attentati di Mumbai e l’italiana ‘ostaggio mancante’ racconta la sua storia di cittadina italiana vittima del terrorismo e poi dimenticata dallo Stato. “Sto ancora aspettando che mi chiamino. Dopo 10 anni, attendo ancora quella chiamata”, dice Mariangela Nieddu, sarda di origine, albergatrice che vive a Venezia e lavora a Verbania e che era a Mumbai quando un commando di terroristi prese in ostaggio un’intera città per 60 ore, uccidendo 166 persone. La telefonata che attende sempre è quella delle autorità italiane, a riconoscimento del fatto che lei era in uno degli alberghi presi di mira. Un silenzio che la consacra, di fatto, come l’ostaggio fantasma di quel maxisequestro, in cui altre sette italiani furono tratti in salvo dopo lunghe ore di terrore.[irp]
Perché Mariangela Nieddu quel 26 novembre del 2008, c’era. Era lì, nell’hotel Trident, attaccato all’Oberoi. E da allora la sua vita è stata scandita dai ricordi difficili da gestire, da una battaglia che sembra non avere fine, passo dopo passo: un percorso pluriennale per far riconoscere i fatti da un organo governativo si è recentemente concluso senza soddisfazione, ora parte l’iter giudiziario e confida che i tanti elementi probatori faranno sì che lo Stato Italiano non possa negare per via giurisdizionale la presenza di Nieddu nell’inferno dell’Oberoi. “Ero in India da qualche giorno, il 26 novembre avevo partecipato a un workshop organizzato da Enit al Trident, dove alloggiavo. Poi – racconta ad askanews, come se fosse accaduto soltanto pochi minuti fa – sono andata a cena nel ristorante dell’hotel e sono risalita in camera sempre senza lasciare l’edificio. Sarei dovuta ripartire l’indomani”.
“Sono salita al 23esimo piano (ho ancora la chiave della stanza 2320), ho aperto la porta della stanza, mi sono tolta le scarpe. Non ho fatto in tempo a svestirmi e ho subito sentito un forte rumore che proveniva dal basso. Ho capito subito che si trattava di una bomba, ma non sapevo se fosse scoppiata dentro l’hotel. I telefoni erano già scollegati, per il mestiere che faccio mi so muovere in un grande hotel – continua come un fiume in piena – sono scesa dalle scale di sicurezza e ho visto il primo morto. Ho capito cosa stava succedendo, sono tornata in camera terrorizzata. Ma non avevo alternative. Ero in un piano alto, se avessero appiccato un incendio non avrei potuto fuggire. Così ho deciso di scendere. Mi sono fatta coraggio e ho trovato una decina di persone che scappavano come me. Ho seguito una hostess della Lufthansa che sembrava calma e sapeva cosa faceva. Ci siamo rifugiati in una sala riunioni e siamo stati lì dalle 21:40 circa alle 3:00 del mattino”.[irp]
Le teste di cuoio erano entrate in azione, ma l’assedio era ancora in corso. “Siamo passati dalla hall con le forze di sicurezza, mentre i terroristi ancora sparavano e poi siamo stati tutta la notte fuori sulla strada, per capire come andare via. Avevo il mio blackberry, con pochissima batteria, era la mia unica ancora di salvezza. Ho avvertito la mia datrice di lavoro che ha avvisato la Farnesina, che ha parlato con il console a Mumbai”. Anche un altro amico di Mariangela informò la Farnesina della sua presenza lì e che era stata presa in ostaggio, ma in quelle ore concitate a lei non arrivò nessuna chiamata. Nessun segnale anche dopo il rientro in patria, niente negli anni a seguire. “Mi dissero di aspettare la chiamata e io, sentendomi grata per essere viva in quella situazione terribile, aspettai. Se l’autorità mi dice di aspettare, io aspetto. Stavo male, ma ero viva. C’era sangue ovunque, odore di sangue, strisce di sangue, avrei potuto fare delle foto, ma non le ho fatte. Se le avessi oggi non saremmo qui”.
Qui significa 10 anni di battaglie legali, 10 anni di cure per superare lo stress post-traumatico, 10 anni di negazione. Oggi 52 anni, Mariangela Nieddu non ha mai mollato. E’ diventata una questione tanto dolorosa quanto di principio. Adesso, entro metà dicembre si apre nuovamente – in ambito giudiziario – il suo caso a un tribunale di Venezia, dopo che a Roma le istanze per essere riconosciuta vittima del terrorismo sono state chiuse con un nulla di fatto. “Da quando sono tornata in Italia, due giorni dopo la fine dell’attentato, dopo giorni in un hotel in cui potevo solo ricevere le telefonate, ho rivissuto quella notte mille volte. Avevo voglia di morire, di suicidarmi (le cose vanno chiamate con il loro nome), avevo bisogno di aiuto e lo dissi anche ai Carabinieri, rilasciando una dichiarazione. Da quel momento la mia richiesta di riconoscimento del mio status si è impantanata. E’ diventata una cosa scottante”, racconta ancora parlando dell’isolamento, della terra bruciata che qualcuno le ha fatto attorno.[irp]
“Sulla tragedia che ho vissuto si innesta una cosa più atroce, questo mancato riconoscimento. E’ una situazione kafkiana. Dicono non c’è nessuna prova che ero lì, ma io c’ero. C’è il visto, l’albergo, c’erano i testi”, ci sono certame”. E’ la voce ferma e salda di una persona che non ha più aspettative. “Non mi aspetto nulla, perché ho capito che hanno già deciso da tempo, hanno deciso una linea per me inaccettabile. Il segno che ti lascia questa cosa è pesante. Negano l’evidenza. C’ero, eccome se c’ero. Ma vado avanti e lo faccio per avere giustizia”. askanews